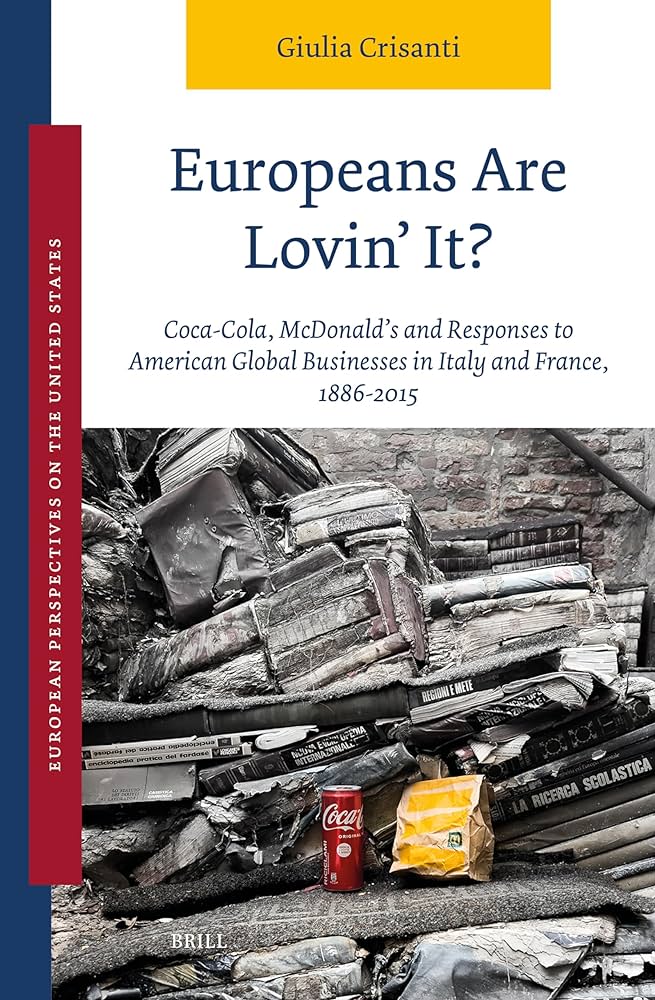
L’altro giorno abbiamo presentato questo libro alla Domus Mazziniana di Pisa, grazie all’iniziativa di Arturo Marzano, con Matteo Pretelli e con l’autrice Giulia Crisanti. Queste sono alcune cose, un po’ aggiustate, fra quelle che ho detto lì. Ci sono anche un paio di cose che lì non ho avuto modo di dire.
Giulia Crisanti, Europeans Are Loving’ It? Coca-Cola, McDonald’s and Responses to American Global Business in Italy and France, 1886-2015 (Brill, Leiden/Boston, 2023)
Diciamo subito le cose ovvie. Questo è un libro di prim’ordine, una ricerca molto estesa per documentazione, per ampiezza geografica e temporale degli archivi consultati. E’ una ricerca molto sofisticata per il tipo di questioni che affronta e di analisi che offre. Fa i conti con la pressoché infinita letteratura storiografica che assedia i suoi temi centrali, business history e storia culturale, storia del cibo e delle abitudini alimentari, storia politica nazionale di almeno tre paesi e storia internazionale del mondo transtlantico dell’ultimo secolo e mezzo. E’ un libro scritto molto bene, è un piacere leggerlo. E’ scritto con grande sicurezza intellettuale. Come oggetto fisico (qualcuno conosce le antiche recensioni televisive della critica letteraria Eva Robbin’s?) è un po’ pesante da portarsi in giro, non lo si porta in giro volentieri. Ha una foto di copertina suggestiva e inquietante. Ha le note-a-pié-pagina – proprio a pié di pagina, alleluia!, e lo si legge volentieri anche per questo.
Aggiungo una ulteriore nota di contesto. Il libro nasce da una tesi di dottorato discussa a Fordham University a New York, premiata dalla European Asssociation for American Studies (EAAS), per questo pubblicata da una casa editrice olandese-americana. Insisto su questo non per mostrare le medaglie, le onoreficienze ricevute, ma per dire un’altra cosa: oltre a essere il frutto della fatica e dell’intelligenza di Giulia Crisanti, questo volume è il frutto di un network transatlantico di studiosi, associazioni, istituzioni che, quando si è affacciata al mondo della ricerca la mia generazione, esisteva molto poco. Oggi una studiosa di storia americana può pubblicare la sua opera prima direttamente in inglese con un editore internazionale come cosa normale, normale nell’eccellenza ovviamente. E quindi il suo lavoro può entrare pienamente e da subito nel dibattito storiografico internazionale. Qualche decennio fa non era così. E insomma, beati voi, beate voi.
¶
Un bel libro dunque, una bella ricerca con una struttura interpretativa che mi sembra convincente. Messa da parte la nozione, da Guerra fredda ma con radici più antiche, che l’americanizzazione sia un processo onnipotente e unidirezionale. Messa da parte la nozione, più recente nel linguaggio anche se non nel concetto, che globalizzazione sia la stessa cosa di americanizzazione. Messa da parte la nozione che il risultato di tutto ciò sia tendenzialmente un mondo reso omogeneo su modelli e stili di vita americani. Ecco, messe da parte queste nozioni qui, dice Crisanti, la storia delle due compagnie e dei due prodotti che più “americani” e “americanizzatori” non si potrebbe, Coca-Cola e McDonald’s, mostra come i processi di interazione e influenza economica e culturale attraverso l’Atlantico siano molto più complessi.
Coca-Cola e McDonald’s fanno parte di processi transatlantici, transnazionali, caratterizzati da scambi diseguali ma reciproci, reciproci ancorché diseguali, fra Stati Uniti e Europa occidentale. Queste caratteristiche sono evidenti alle origini della storia, al momento dell’invenzione, del concepimento del prodotto; c’è il vin Mariani franco-corso (vino bordeaux e estratto di foglie di coca) che diventa l’intruglio parecchio depotenziato della Coca-Cola, e c’è la polpetta all’amburghese che diventa la polpetta americana (su questa faccenda delle origini tornerò brevemente in conclusione). Queste caratteristiche sono evidenti anche alla fine della storia, oggi; per esempio, per conquistare lo stomaco degli europei McDonald’s ha fatto aggiustamenti sostanziali nell’offerta dei suoi menù. E questa è esperienza comune di chi li assaggi in paesi diversi.
I tempi di questi sviluppi sono diversi. Coca-Cola ha una storia di un secolo e mezzo, McDonald’s di mezzo secolo. Insieme coprono il “lungo secolo americano”, e ciò rende le loro vicende particolarmente utili per comprenderlo. Crisanti racconta come i loro successi siano legati a due scelte di fondo: avere una struttura “multilocal” e agire con strategie “glocal” (il vecchio slogan, “pensa globalmente, agisci localmente”). Queste due scelte hanno reso possibile il loro approccio di imprese globali capaci di adattarsi con flessibilità alle dimensioni locali al fine di vendere meglio i loro prodotti e i loro processi produttivi. I loro prodotti in senso lato: bibite e hamburger, certamente, ma forse soprattutto i modi di consumarli, bibite “democratiche” eguali per tutti e i riti del fast food. I loro processi produttivi e distributivi: pratiche tipo il franchising e l’outsourcing, che coinvolgono i businesses locali, e una organizzazione scientifica del lavoro basata sui McJobs poco qualificati e part-time.
¶
Più Coca-Cola e McDonald’s si espandono globalmente, più diventano glocal, con processi di “appropriazione selettiva”, di adattamento selettivo di modelli che si vorrebbero universali a costumi e interessi locali (la categoria di “appropriazione selettiva” viene dallo storico olandese Rob Kroes, nel cui nome è stato istituito il premio della EAAS vinto da Crisanti). Ciò avviene grazie a forze che premono dall’interno e dall’esterno e che il libro esamina con attenzione a proposito di due specifiche esperienze nazionali, quella francese e quella italiana, a loro volta simili ma anche diverse fra loro. Sono esperienze simili perché sia in Francia che in Italia ci sono culture consolidate che favoriscono reazioni di resistenza anti-americana e anti-globale. E cioè forti culture politiche (comuniste negli anni della Guerra fredda ma non solo) e forti culture gastronomiche, forti tradizioni culinarie-alimentari.
I due paesi sono anche diversi. In Francia ci sono forme più radicate e durature di opposizione e resistenza nazionalista e identitaria, centralizzata intorno a Parigi, arroccata intorno a una haute cuisine molto elitaria. C’è questa citazione strepitosa dal settimanale Time del 1950: la resistenza contro la Coca-Cola viene da una “alleanza empia, innaturale, fra comunisti e viticoltori francesi”. L’Italia sembra per alcuni versi più accogliente, qui le temibili bottigliette di Coca-Cola arrivano piuttosto presto alle feste dell’Unità. Per altri versi, è più difficile da conquistare per McDonald’s, che risulta più alieno e intrusivo in una realtà che ha abitudini di cucina popolare e forme autoctone diffuse e decentrate di cucina veloce, di cibo di strada, che a McDonald’s fanno argine e concorrenza. L’Italia sembra anche più adatta alla nascita di movimenti critici contro-egemonici, meno in opposizione e più in alternativa, anch’essi glocal: se c’è il fast food, si dice, che ci sia anche Slow Food (che sembra un movimento più vitale e duraturo di quello parallelo di José Bové in Francia).
Parlando dei movimenti come Slow Food e di altro tipo, più popolari e più radicali, che reagiscono in maniera critica alla globalizzazione e che occupano l’ultimo capitolo del libro, Crisanti la butta un po’ in politica. Per meglio dire, ne parla con una passione che è non solo interpretativa, come in tutto il testo che precede, ma anche partecipante. C’è un code switching nel linguaggio, che passa dall’analisi alla advocacy, alla militanza. Che sottolinea non ciò che accade ma ciò che dovrebbe accadere. Che si interroga su possibili “lezioni per il futuro”. Sembra che “think globally, act locally” debba continuare a essere il principio ispiratore dei movimenti critici e alternativi alla globalizzazione, come lo era prima di essere adottato anche dal business multinazionale. Chissà che questi movimenti non possano o debbano adottare anche principi organizzativi come il franchising o l’outsourcing. O forse lo fanno già, l’hanno sempre fatto.
¶
Il libro è pieno di suggestioni, e vorrei concludere inseguendone un paio.
La prima, come promesso, riguarda l’origine dei prodotti di cui stiamo parlando. Coca-Cola e Big Mac nati in Europa, trasformati in America con i modi di produzione e consumo americani, esportati e percepiti come icone Made in the USA. Completiamo pure il menù con le patate fritte, cioè le French fries. Tutto ciò è frutto di contaminazioni transtlantiche. In varie occasioni Crisanti scrive: “Molte delle cose che hanno finito per rappresentare l’America erano, in effetti, definite e plasmate all’estero”. Ma questa è la definizione stessa di America! Gli Stati Uniti d’America sono quella cosa lì, storicamente fatti di elementi definiti e plasmati all’estero, in Europa almeno fin’ora, e lì ricombinati in maniera nuova. D’altra parte, restando ai prodotti di consumo più iconici, non è questa la stessa storia dei blue jeans fatti di tela blu di Genova? O dell’espresso che diventa Starbucks? O della festa dei morti che ritorna in Europa come Halloween? O del Natale nordico con l’albero e Santa Klaus, “inventato” dalla Coca-Cola appunto? O dei film classici di Hollywood che più Old-Europe rinfrescata in America non si può?
La seconda suggestione è questa. Sì, esiste l’idea di un “approccio privato alla politica estera” degli Stati Uniti, l’idea che l’esportazione dell’America, della sua capacità di sedurre (quando seduce) e di conquistare (quando conquista), siano spesso prodotti del settore privato, del mercato dei modi di produzione e dei consumi. E che proprio per questo Coca-Cola e McDonald’s siano importanti da studiare come il Dipartimento di Stato o il Pentagono. Naturalmente si sa bene che spesso il governo ha agito da facilitatore o veicolo diretto di pressione di queste esportazioni. C’è la sublime lamentela di Le Monde del 1973: “se in Francia beviamo Coca-Cola, è per via delle portaerei americane”. Ma certo, in prospettiva comparata, nel soft power americano c’è più mercato e meno stato di quanto accada per altri paesi. Fra l’altro questo era il senso dell’American Century evocato dall’editore Henry Luce nel suo celebre articolo del 1941. Era anche ciò che scriveva Tocqueville due secoli fa in Democracy in America: ci sono due grandi nazioni in espansione, la Russia e l’America, la Russia lo fa con il potere autoritario e la servitù, l’America con la libertà e la forza dell’interesse personale.
¶
Post scriptum: altre due suggestioni, dettagli.
Sembra che ci siano momenti in cui questi prodotti di massa, così volgari, passano per roba d’élite, scic, fighetta, almeno in Francia. Leggo che nella Parigi dell’immediato dopoguerra la Coca-Cola si consumava soprattutto a Saint-Germain-des-Prés, in posti leggendari come la Brasserie Lipp, il Café de Flore. Insomma, dalle parti di Jean-Paul e Simone? Più probabilmente dalle parti di giovani esistenzialisti, tutti blue jeans e jazz? O magari di espatriati americani? Una quarantina d’anni dopo tocca non alla bibita ma al panino. Un uomo d’affari segnala i primi McDonald’s come “qualcosa di nuovo, qualcosa di snob e di molto parigino”, praticamente sconosciuti nel resto del paese. E qui chi sarà a consumare i Big Mac avant-garde? I giovani bobo, bourgeois-bohème, che sanno chi è Andy Warhol? A Roma, per dire, le reazioni al primo ristorante McDonald’s, enorme, niente di meno che a Piazza di Spagna, sono diverse: grida di violazione del decoro del centro storico, grida di scandalo perché il locale attrae nel quartiere del lusso i ragazzotti delle periferie, i borgatari.
E poi c’è l’uso di simboli americani, compresi quelli commerciali, da parte dei movimenti europei che, ai tempi, contestavano la guerra americana in Vietnam, l’imperialismo americano, il capitalismo americanotout court. Crisanti cita il film di Godard, Maschile, femminile (1966), che parla dei giovani come “figli di Marx e della Coca-Cola”. Evoca una immagine ulteriore, secondo cui c’era ormai l’abitudine a vedere “gruppi di giovani hippy con le bandiere Vietcong, i simboli della pace e abiti colorati, tutti bevendo Coca-Cola”. Ecco, questa è un’immagine di sintesi un po’ troppo sintetica, una fantasia da Mulino Bianco morboso di qualche giornalista. Una cosa era vera, tuttavia. E cioè gli Stati Uniti erano un supermercato con molti prodotti culturali di massa fra cui scegliere per dire quello che si voleva dire, anche contro l’America. Un paradosso, e di sicuro una delle forze del soft power yankee. A certe manifestazioni, chi non è andato, non si dica in jeans, che è una banalità, ma con quelle giacche verdi da Army Surplus che si compravano ai mercatini americani? Giacche da marine, Semper Fidelis.
- Trump, Biden, e le tribolazioni di una democrazia di immigrati / 04
- Trump, Biden, e le tribolazioni di una democrazia di immigrati / 05 e fine, almeno per ora
Categorie:Uncategorized
